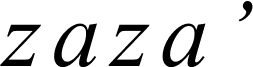
Gina Fischli
The Ballad of the Sad Cafè
1 / 0
Il titolo della mostra rimanda al racconto di Carson McCullers ‘The Ballad of the Sad Café’, una narrazione costruita attorno al desiderio diseguale e a forme instabili di comunità. Nel lavoro di Fischli, la comunità appare come una condizione modellata da accesso, dipendenza ed esposizione, più che come uno spazio di appartenenza reciproca. Il riferimento a McCullers inquadra la mostra come un’indagine su come l’“essere insieme” venga organizzato e messo sotto pressione da assetti economici e sociali che restano in gran parte impliciti.
Le opere nascono da fotografie realizzate dall’artista durante le sue esplorazioni di hotel di lusso, principalmente a Parigi. Questi interni vengono letti come tracce materiali di una formazione storica specifica: il linguaggio estetico sviluppatosi insieme al capitalismo neoliberale. Gli hotel emergono come nodi di un’economia strutturata attorno alla mobilità, all’astrazione finanziaria e alla gestione dell’esperienza. La loro coerenza stilistica — tonalità neutre, atmosfere curate, variazione controllata — segnala l’emergere di una lingua spaziale globale progettata per circolare senza attrito tra città e culture.
Questo sguardo è segnato anche dalla formazione di Fischli a Londra negli anni Dieci, un decennio in cui la città ha funzionato insieme come laboratorio e vetrina della logica culturale del capitalismo finanziario, e in cui l’estetica dell’“interno globale” ha raggiunto una saturazione e un’autosufficienza che oggi appaiono storicamente determinate. In questi ambienti, la località si dissolve nella riconoscibilità. La differenza culturale viene riformattata come superficie. Il comfort diventa una configurazione economica, più che una semplice promessa. Hall e lounge agiscono come spazi di transizione all’interno delle reti del turismo, della finanza e dell’investimento, producendo un’atmosfera di fluidità che rispecchia la presunta scorrevolezza dei flussi economici.
Le immagini di Fischli intercettano questi interni in un momento in cui lo stile culturale associato al neoliberismo non appare più inevitabile. Ciò che prima proiettava apertura e universalità oggi si manifesta come ripetizione. L’interno globale comincia a rivelarsi meno come orizzonte e più come sistema, la cui grammatica diventa evidente proprio attraverso la sua saturazione.
Questa lettura prende forma attraverso una pratica che si muove tra ricerca fotografica e pittura concettuale. Le fotografie sono il risultato di un contatto diretto con gli spazi e le pitture funzionano come cornici espanse di quegli incontri. La pittura non traduce l’immagine fotografica in un altro linguaggio, ma la dilata e la destabilizza. Introduce ritardo, discontinuità e pressione materiale in un campo visivo altrimenti organizzato per immediatezza e controllo. Dove la fotografia stabilisce una struttura, la pittura la redistribuisce; dove l’immagine stabilizza l’interno, il colore ne incrina la coerenza.
L’artista ha descritto gli elementi fotografici come simili a pop-up pubblicitari: intrusioni nella libertà e nell’apparente innocenza della pittura che agiscono come un reality check o persino come una forma di memento mori. La fotografia non interviene come illustrazione ma come interferenza — come traccia di un sistema esterno che entra nell’immagine e ne mina l’autonomia dall’interno.
In questo processo, la pittura diventa un modo di pensare le condizioni che hanno prodotto l’immagine. L’espressività opera come frizione analitica più che come gesto personale. Le opere restano immerse nella logica visiva che analizzano, lasciando emergere trame, ritmi e ridondanze senza risolversi in una critica esterna.
La mostra non propone ambienti alternativi né modelli di comunità da recuperare. Rimane invece attenta a ciò che questi interni rivelano sulle condizioni in cui oggi si organizza la vita sociale e al modo in cui le immagini partecipano a questa messa in scena. Ciò che emerge è meno un’argomentazione che una situazione — in cui comfort, accesso e neutralità estetica non possono più essere assunti come dati, e in cui la grammatica dell’interno globale comincia ad apparire come storica piuttosto che naturale.
ENG
The exhibition takes its title from Carson McCullers’ novella ‘The Ballad of the Sad Café’, a narrative structured around unequal desire and unstable forms of community. In Fischli’s work, community appears as a condition shaped by access, dependency, and exposure rather than mutual belonging. The reference to McCullers frames the exhibition as an inquiry into how togetherness is organized and strained by economic and social arrangements that remain largely implicit.
The works originate from photographs Fischli took herself while moving through luxury hotels, primarily in Paris. These interiors are approached as material evidence of a specific historical formation: the aesthetic language developed alongside neoliberal capitalism. Hotels appear here as sites within an economy structured by mobility, financial abstraction, and the management of experience. Their stylistic coherence — neutral tones, curated atmosphere, controlled variation — signals the emergence of a global spatial language designed to circulate seamlessly across cities and cultures.
This focus is also shaped by Fischli’s formation in London in the 2010s, a decade in which the city functioned as both laboratory and showroom for the cultural logic of financial capitalism, and in which the aesthetic of the “global interior” reached a level of saturation and self-confidence that now reads as historically specific. Within these environments, locality dissolves into recognizability. Cultural difference is reformatted as surface. Comfort becomes an economic arrangement rather than a simple promise. Lobbies and lounges operate as transitional architectures within networks of tourism, finance, and investment, producing an atmosphere of smoothness that mirrors idealized economic flows.
Fischli’s images register these interiors at a moment when the cultural style associated with neoliberalism no longer appears inevitable. What once projected openness and universality now reads as repetition. The global interior begins to reveal itself less as horizon and more as system, its language becoming visible through saturation. This reading is developed through a practice that moves between photographic research and conceptual painting. The photographs were made through direct encounters with these spaces, and the paintings function as expanded frames for those experiences. Painting stretches the photographic image rather than translating it. It introduces delay, inconsistency, and material pressure into a visual field otherwise organized around immediacy and control. Where photography establishes structure, painting redistributes it; where the image stabilizes the interior, paint unsettles its coherence.
The artist has described the photographic elements as behaving like pop-up ads: intrusions into the freedom and apparent innocence of painting that function as a reality check or even a form of memento mori. Photography appears not as illustration but as interruption — a reminder of an external system pressing into the autonomy of the image and disrupting the pictorial surface from within.
Within this process, painting becomes a way of thinking through the conditions that produced the image in the first place. Expressivity operates as analytic friction rather than personal gesture. The works remain embedded in the visual logic they examine, allowing rhythms, textures, and repetitions to surface without resolving into critique from a distance. The exhibition does not propose alternative environments or recover lost models of community. It remains attentive to what these interiors reveal about the conditions under which social life is staged today, and to how images participate in that staging. What emerges is less an argument than a situation — one in which comfort, access, and aesthetic neutrality can no longer be taken at face value, and in which the grammar of the global interior begins to appear as historical rather than natural.






